Effettivamente questo versetto stona moltissimo, tanto a livello di concordanza teologica, quanto a livello di rispondenza logica:
«Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando» (Gv 15, 14).
Stona a livello teologico, in quanto al Signore non appartiene l’atto dell’imporre, quanto del proporre; in quanto al Signore appartiene l’invitare, non il comandare.
Il dono più grande che il Signore ha concesso all’uomo è proprio la libertà, difatti Egli ci ha lasciati liberi: liberi di scegliere tra il bene e il male; liberi di sceglierlo; liberi di divenire o meno suoi amici.
Ed è affermazione incontestabile come un vero amico, il vero amico, non sia colui che nega sempre quello che io nego, e che afferma sempre quello che io affermo, ovvero che dice e fa esattamente quello che io gli comando di fare e dire, ma sia colui che, nel pieno esercizio della sua libertà, concorda con me se è bene e giusto concordare, ma con me dissente se è giusto e bene dissentire.
Altrimenti non si tratta di amicizia, bensì di servitù, o peggio schiavitù, fino a degenerare nel più viscido (ci si consenta un termine non codificato ma alquanto esplicativo) “lacchismo”.
L’amicizia, invero, non implica mielosa prostrazione, e non fa rima con schiavitù o servitù, ovvero con il comandare: eppure il Signore riconosce come suoi amici proprio coloro che obbediscono al suo comando.
Da ciò, ecco l’altro livello di stonatura: quella logica, la quale è, come appena spiegato, palesemente manifesta nel versetto già citato, e viene a ribadirsi anche nel versetto immediatamente seguente:
«Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi» (Gv, 15, 15).
Ma come può esserci amicizia se dall’amico si pretende cieca ed integerrima obbedienza al proprio comando? Come si può negare la qualità di servitù al destinatario di un comando?
Quante volte mi sono posto questa domanda, e quante volte, ascoltando o leggendo questo passo, sono rimasto confuso e stordito dall’asprezza della sua acuta stonatura.
Certamente il confronto con un padre spirituale, in questi casi, è fondamentale, affinché la Parola di Dio non rimanga abbandonata alla nostra insolente, presuntuosa, ma arida, interpretazione, ovvero manipolazione, e non ci induca nella tentazione “eisegetica” di foggiare, o forgiare, un “Dio come dico io”, un “vitello d’oro” (cf. Es 32, 4) a cui tiriamo o molliamo le briglie così come ci fa comodo.
Tuttavia, anche uno studio attento e rispettoso della Scrittura, potrebbe aiutarci a comprendere quello che, in nuce, la Parola di Dio riesce a veicolare e rivelare, sempre attenti a ricordare, come diciamo sempre fino ad annoiare il lettore, come la Parola di Dio non sia solo “storia” (lettura letterale) o solo kérygma (lettura teologica), bensì un “et-et”, ovvero “e storia e kerygma”.
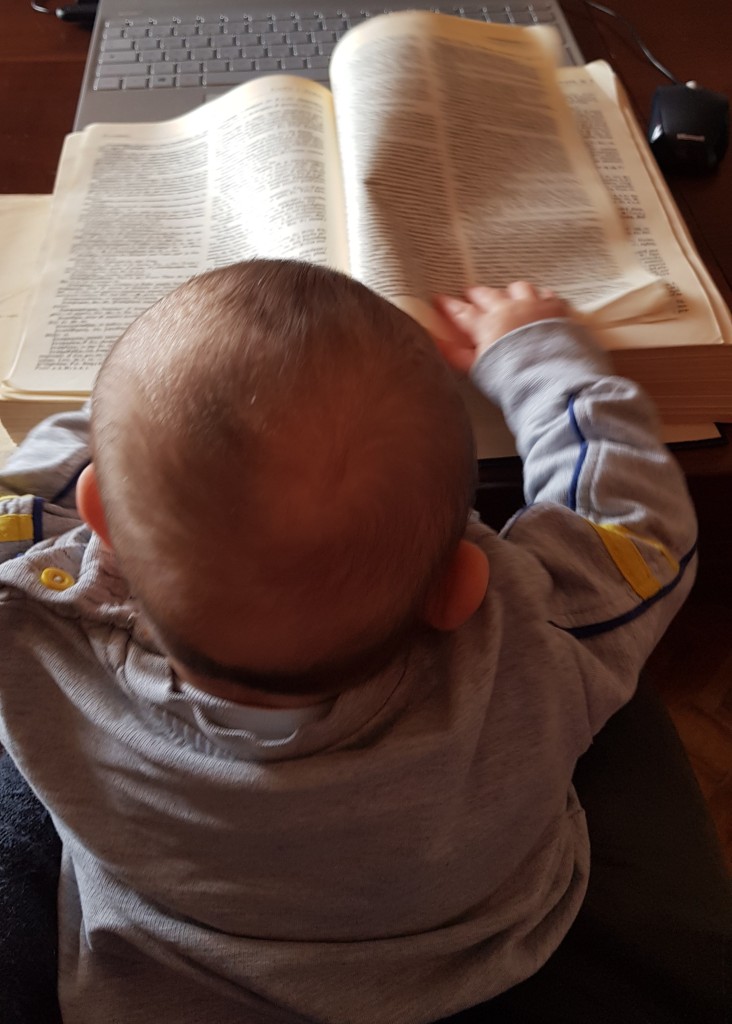
Detto ciò, il verbo usato nel greco originario del Vangelo odierno, ovvero entéllo/entéllomai intende esattamente «comandare/ordinare/imporre/ingiungere».
E questa lettura “storica”, ovvero letterale, deve essere certamente riconosciuta ed accolta.
Difatti, se l’amico in questione è Gesù Cristo, come non possiamo non obbedire ai suoi “comandi”? Egli che per primo ha «osservato i comandamenti» del Padre (cf. Gv 15, 10).
Invero, abbiamo detto che l’amico vero ha il dovere di concordare se è bene e giusto concordare: e come è possibile non concordare con i precetti del Signore, come è possibile non ubbidire ai comandamenti del Signore, Egli che è Via, Verità e Vita (cf. Gv 14, 6)?
Dissentire dinanzi al comando del Signore, infatti, non è esercizio di libertà di un vero amico, bensì atto di vanagloria di un superbo nemico.
Nondimeno, cerchiamo di scendere nella profondità di questo termine così particolare, ovvero che diventa così particolare dato il contesto in cui è inserito.
Il verbo entéllo/entéllomai, invero, è espressione di un concetto più profondo della mera, scarna e cruda, imposizione, poiché esso intende propriamente una completezza, una pienezza, e più che «comandare» in senso stretto, esso esprime, nel suo impulso intimo, un «compiere», ovvero un «essere intero/perfetto»: difatti entéllo («comandare») è direttamente in rapporto con télos, ovvero «compimento/pienezza di risultato».
Proviamo, allora, a rendere il versetto di Gv 15, 14, introducendo l’analisi semantica che abbiamo indicato:
«Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi compio».
Chiaramente il senso rimane ancora un po’ celato.
Ci facciamo aiutare nella comprensione dal dativo umīn, ovvero dal pronome «vi».
In greco, il dativo esprime principalmente il complemento di termine, che può essere reso in traduzione tanto con l’ordinario «a voi», quanto con il cosiddetto “dativo di interesse”, ovvero «per voi».
Torniamo, allora, ad esplicitare esegeticamente il versetto in questione:
«Voi siete miei amici, se fate ciò che io per voi comando», dove il «per voi» può valere sia come «voi siete i destinatari del mio comando, quindi a voi spetta obbedire», ma anche «voi siete i destinatari del mio comando, quindi quanto io comando è a vostro vantaggio e beneficio».
Ma il senso pieno del versetto lo si può desumere se esplicitiamo la riga in questione traducendo entéllo con «compiere»:
«Voi siete miei amici, se fate ciò che io per voi compio».
Ecco come il senso profondo del versetto, superando ogni possibile fraintendimento, riesce, dal suo intimo, a venire in superfice: voi siete miei amici non tanto, o non solo, se obbedite al mio comando, bensì se fate quello che io (per primo) porto a compimento per voi, ovvero se confermerete, o ancor più forte, se imiterete e testimonierete quanto io (prima di chiedere a voi di farlo) sto ora facendo interamente, perfettamente e pienamente per voi.
Ma cosa sta compiendo pienamente Gesù per coloro, ovvero a vantaggio di coloro, che Egli definisce suoi amici?
Ecco che il senso del versetto in esame (Gv 15, 14) non va trovato tanto nella riga seguente (Gv 15, 15), ma in quella precedente:
«Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici» (Gv 15, 13).
Difatti, il capitolo 15 secondo Giovanni è a ridosso della Passione di Gesù, la quale è pienamente l’atto supremo che il Signore compie a vantaggio nostro, a vantaggio degli uomini, che il Signore vorrebbe fossero tutti suoi amici, quindi che fossero tutti beneficiari del suo sacrificio di amore, ben sapendo però che l’amicizia col Signore sarà perfetta solo se sapremo anche noi compiere lo stesso amore che Egli ha compiuto per noi, se sapremo ri-fare quanto Egli ha fatto: «Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13, 35). -Ricordiamoci sempre, però, come Gesù sia il Christós (il «Messia», ovvero l’ «Unto di Dio»), non il chrestós («bonaccione/sempliciotto»)
Chiudiamo con due note a corollario, che riescono ad offrirci una portata più ampia del verbo (entéllo) e del contenuto che abbiamo analizzato.
Il verbo entéllo, ovvero «comandare», ma meglio «compiere pienamente/perfettamente», come detto, è in piena sintonia con il sostantivo télos, ovvero «compimento/pienezza di risultato».
Quest’ultimo nome lo troviamo nel pieno della sua forza espressiva in Gv 13, 1:
«Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine».
L’espressione «fino alla fine» nel greco originario è, infatti, eis télos che intende, ora o sappiamo bene, non tanto che Gesù amò (e ama) i suoi discepoli fino a quando tutto si sarà concluso e spento («fino alla fine» appunto), ma il Signore «li amò fino al fine», ovvero «fino al compimento pieno», fino alla perfezione: poiché la Croce non è stata la fine di tutto, ma il fine di tutto; poiché con la Croce non si è concluso e spento tutto, ma con essa tutto si è acceso, poiché tutto è giunto a compimento.
Ed ecco la seconda nota.
Cosa ha pronunciato, invero, Gesù in croce, proprio alla fine, quanto tutto stava finendo (ovvero quando tutto stava raggiungendo non la fine ma il fine, il compimento e la perfezione)?
«Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: “È compiuto!“. E, chinato il capo, consegnò lo spirito».
E il verbo adoperato è tetélestai (coniugato da teléo), esattamente derivato da télos, ovvero direttamente connesso a entéllo.
Difatti il Gesù in croce, secondo Giovanni, è un Gesù in trono, un Gesù compiutamente e pienamente glorioso.
Terminiamo, infine, con l’ultimo dettaglio.
Nel Vangelo secondo Giovanni non è narrata l’Ultima Cena, ma questo episodio viene “richiamato”, in questo medesimo testo evangelico, in altri momenti (es. il capitolo 6 in cui si tratta del cosiddetto “Pane di Vita”).
Ebbene, potremmo esegeticamente richiamare l’Ultima Cena anche nella parte di versetto che abbiamo esaminato oggi, poiché nell’espressione: «[Voi siete miei amici, se] fate ciò che io per voi compio», alla luce di tutto quello che abbiamo evidenziato nel nostro commento, potremmo benissimo renderla come il calco dell’espressione che troviamo in Lc 22, 19: «[… Questo è il mio corpo, che è dato per voi;] fate questo in memoria di me».




