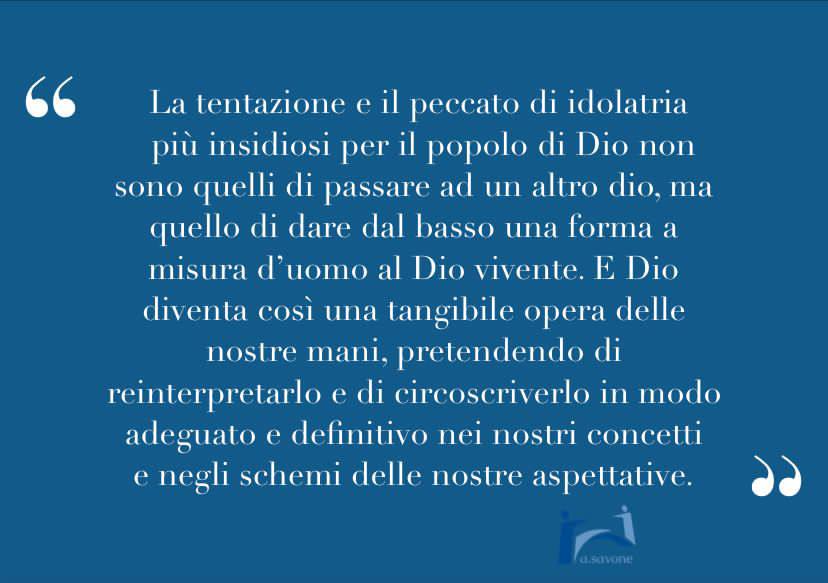
Patiamo tutti sulla nostra pelle la fatica a stare a contatto con l’assenza, con il vuoto, con ciò che non avevamo messo in conto, con l’alterità: restiamo interiormente destabilizzati. Meglio venire a patti con le nostre paure e trovare l’anestetico di turno che si solito individuiamo in qualcosa che ci assomiglia e in cui è facile riconoscerci, una sorta di incarnazione del nostro delirio di onnipotenza.
Non è facile avere a che fare con l’altro e con il suo modo di manifestarsi, sia esso Dio o chi ci sta di fronte. È più facile dilatare noi stessi fino ad offuscare il volto dell’altro. E, così, invece di cogliere quale parola sia racchiusa per noi quando appunto siamo chiamati a fare esperienza della distanza rispetto a noi da parte di Dio o dell’altro, preferiamo colmare quel vuoto con un’immagine che ci assomigli e ci rassicuri.
Oggi, forse, siamo meno dozzinali del popolo d’Israele e non arriviamo ad attribuire la nostra liberazione ad un vitello piuttosto grossolano. Altre sono le realtà che lo hanno rimpiazzato: il bisogno di riconoscimento, l’esercizio dispotico del potere, l’ansia di restare sempre connessi con i moderni strumenti della comunicazione. Il contatto con il vuoto ci destabilizza e perciò abbiamo bisogno di riempirlo con ciò che secondo noi può rappresentare la via d’uscita. Finiamo così per dare nomi altisonanti a realtà di cui conosciamo già la loro inconsistenza. Ma, pur essendone consapevoli, preferiamo accontentarci della nostra piccola vita anziché lasciarci condurre dallo stesso Dio per i sentieri che egli va tracciando per noi.
A scribi e farisei allora, a noi oggi, Gesù ripete: guai a concepire il rapporto con Dio come la proiezione dei nostri bisogni o delle nostre paure. Dio è altro, è oltre le nostre proiezioni e paure.
Dio parla a noi sempre, in modi diversi e non secondo le nostre aspettative. Il problema, al dire di Gesù, è quanto davvero desideriamo “avere vita”. Quando questo desiderio è stato soffocato, nulla è più eloquente; quando, invece, questo desiderio è vivo e sincero, tutto diventa sacramento del Padre, persino lo stile dimesso del Figlio e l’esperienza contraddittoria e fallimentare della passione (come insegnerà la vicenda del centurione pagano).
Troviamo nella Parola odierna la tentazione a cui siamo continuamente sottoposti: la pretesa di ridimensionare il Signore e a farne l’opera delle proprie mani: “Facci un dio!”. Il culto del vitello d’oro non si esprime come il passaggio al culto di un altro dio. La tentazione e il peccato di idolatria più insidiosi per il popolo di Dio non sono quelli di passare ad un altro dio, ma quello di dare dal basso una forma umana – a misura d’uomo – al Dio vivente. E Dio diventa così una tangibile opera delle nostre mani, pretendendo di reinterpretarlo e di circoscriverlo in modo adeguato e definitivo nei nostri concetti e negli schemi delle nostre aspettative. È sempre ricorrente la tentazione di non riconoscere e, perciò, non accogliere, un Dio che si rivela nella leggerezza di un volto o attraverso una parola delicata e uno stile dimesso. È sempre dietro l’angolo il rischio di non accettare un Dio che non si mostra con prove evidenti ma che fa appello alla fiducia del cuore. Cosa ce ne facciamo di un Dio così? Troppo poco per essere rassicurati.
Il vitello d’oro è un’immagine di forza che s’impone. Tutte le volte che Dio ci fa entrare nell’esperienza del vuoto della sua presenza (era accaduto così ad Israele che mal sopportava quel lungo permanere di Mosè sul monte), noi preferiamo scegliere soluzioni che riempiano quel vuoto finendo per attribuire alla prestanza di una statua d’oro l’elogio della liberazione. Facciamo fatica a stare a contatto con la dinamica dell’assenza in cui Dio ci fa entrare per vedere cosa c’è davvero nel nostro cuore.
Difficile il percorso verso la libertà: meglio accontentarsi della sicurezza delle cipolle dell’Egitto.
Ora comprendiamo così perché Gesù avesse chiesto a quel paralitico che da 38 anni era infermo: “Vuoi guarire?”.
AUTORE: don Antonio Savone
FONTE
CANALE YOUTUBE
TELEGRAM
